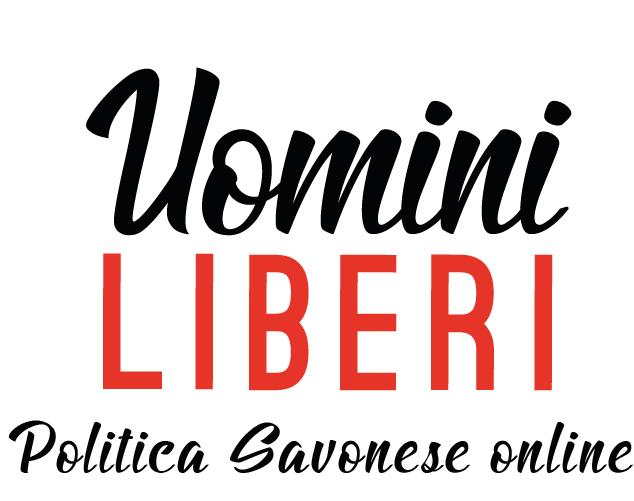Priamàr, la cattedrale ritrovata
Era coperta dalla Cittadella
Il cuore religioso della Savona medievale scomparve per secoli, nascosto dalle nuove strutture militari genovesi. Dopo una prima campagna nel 1956 tanti reperti riportati alla luce a partire dal 2007″
Collochiamo i fatti nel tempo: siamo nel 1528 e Savona è caduta. Dopo anni di conflitti, i Genovesi hanno chiuso la partita. La punizione inflitta è esemplare e si riassume in poche decisioni: il porto sarà interrato, mentre l’antica Cattedrale di Santa Maria, il palazzo vescovile, gli oratori saranno distrutti. Nel volgere di pochi anni l’intero colle del Priamàr viene trasformato in un’imponente fortezza. In un primo momento le truppe genovesi utilizzano il duomo e il chiostro come caserma. Al 1595 si data la definitiva distruzione della cattedrale per fare posto alla nuova Casa del Commissario della Cittadella.
Il cuore religioso della Savona medievale, quindi, scomparve per secoli, coperto dalle nuove strutture militari genovesi. Della cattedrale di Santa Maria restò il ricordo, insieme ad una meticolosa descrizione cinquecentesca di Ottobono Giordano, almeno fino all’avvio degli scavi archeologici. Nel 1956 Nino Lamboglia, padre dell’archeologia ligure, decise di avviare le indagini all’interno della fortezza del Priamàr, partendo proprio dall’area dell’antica cattedrale. Le sue ricerche proseguirono fino al 1958. Furono indagati diversi vani appartenenti alla Casa del Commissario, ma le tracce dell’antico duomo sembravano piuttosto limitate e indussero Lamboglia a spostare gli scavi in altre zone della fortezza. Dopo una lunga interruzione, nel 2007 sono riprese le ricerche archeologiche, sotto la direzione di Carlo Varaldo e Rita Lavagna. Gli scavi sono condotti dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri con la collaborazione della Cattedra di Archeologia medievale dell’Università di Genova e del Civico Museo Archeologico di Savona. L’indagine è iniziata con lo studio degli edifici militari genovesi, per poi portare in luce le macerie del complesso della cattedrale e del Chiostro dei Canoni- ci. La distruzione attuata dai genovesi è stata indubbiamente radicale. Grazie agli scavi, oggi conosciamo l’area absidale, il muro perimetrale di Ponente e parte della facciata della chiesa, emersa di recente nel piazzale della Cittadella. In base ai rilievi, la chiesa risulta molto più grande di quanto precedentemente ipotiz- zato (61 m di lunghezza). Nell’area della navata centrale sono presenti tracce della preparazione della pavimentazione e una sepoltura in cui riposano almeno tre inumati. Doveva trattarsi di persone importanti, vi- sta la posizione privilegiata di seppellimento: esattamente davanti ai gradini che portavano ad un vano ribassato: la cripta, direttamente scavata nella roccia. Le fasi medievali — come vedremo in seguito — sono precedute dai resti di un muro e da alcune sepolture altomedievali.

Le strutture del Chiostro dei Canonici sono risultate meglio conservate. Al di sotto delle macerie di demolizione sono emersi alcuni degli ambienti originali. Nella seconda metà del XVI secolo, prima della loro distruzione, furono trasformati e occupati dalle truppe genovesi. In particolare, uno di questi vani fungeva, probabilmente, da cucina. In un secondo ambiente, sotto alle pavimentazioni, sono stati ritrovati due pozzetti delle acque scure. Lo scavo ha fornito interessanti dati sull’alimentazione delle truppe genovesi e sulle dotazioni di vasellame da cucina e da mensa del presidio militare.
Queste fasi di utilizzo più tarde nascondono le testimonianze dell’uso medievale funerario del chiostro. Sono emersi loculi in muratura che conservavano al loro interno quasi esclusivamente ossa lunghe (femori, tibie, omeri) e crani. Si tratta di sepolture “secondarie”. Questo significa che i resti scheletrici sono stati riesumati dalle sepolture originali e trasferiti nei loculi in un secondo momento. In uno dei vani è stato rinvenuto un loculo con murature costruite in spezzoni di “pietra del Finale”. Originariamente doveva essere coperto da una lastra di marmo, documentata da numerose schegge in parte combuste. All’interno della sepoltura erano presenti gli scheletri di diversi individui, deposti progressivamente nel tempo.
La nuova fase di campagne di scavo ha portato contributi ad una delle questioni più dibattute dalla storiografia locale: il tema del trasferimento della sede episcopale da Vado a Savona. Tra le macerie che riempivano gli ambienti del chiostro, oltre a colonnine e capitelli di datazione più recente, è emerso un frammento di lastra in marmo con decoro a rosetta ad otto petali, databile alla prima metà dell’VIII secolo. Utile ricordare che, negli anni ’70, era già stato recuperato un frammento di pluteo marmoreo con decorazione ad intreccio, datato alla metà del IX secolo. Si tratta di due elementi decorativi appartenenti ad una prima chiesa altomedievale e il loro ritrovamento pone interessanti problemi di cronologia. Gli scavi hanno fornito altri indizi. Tra IV e VII secolo, l’area nord est della sommità del colle del Priamàr era occupata da una necropoli con tombe direttamente scavate nella roccia. Nell’area della cattedrale, sotto alle fasi medievali, gli scavi hanno riportato in luce un muro perimetrale e alcune sepolture sicuramente databili all’altomedioevo. Questi elementi consentono di ipotizzare la presenza di un primo edificio di culto, poi distrutto per costruire la cattedrale romanica.
A chi apparteneva questa chiesa? Che funzione poteva avere?
Il primo vescovo ricordato dalle fonti ecclesiastiche nel 580 si chiamava Benedetto e aveva la sua sede a Vado. Romolo, che è menzionato nell’887, era sicuramente insediato sul colle del Priamàr. Il ritrovamento di elementi decorativi di cronologia più antica ha fatto ipotizzare che il vescovo Stadelberto, che partecipò al Sinodo di Milano nell’864, benché ancora ricordato come “vadese”, risiedesse già a Savona e, quindi, che il trasferimento della sede episcopale fosse già avvenuto da qualche tempo.
Il mistero, ad oggi, è ancora irrisolto, ma Carlo Varaldo, Rita Lavagna e l’Istituto di Studi Liguri continuano con impegno e passione le loro ricerche sull’antico colle del Priamàr.
di Giada Molinari Dipartimento di Antichità, Filosofia e storia Università di Genova borsista di ricerca da La Repubblica